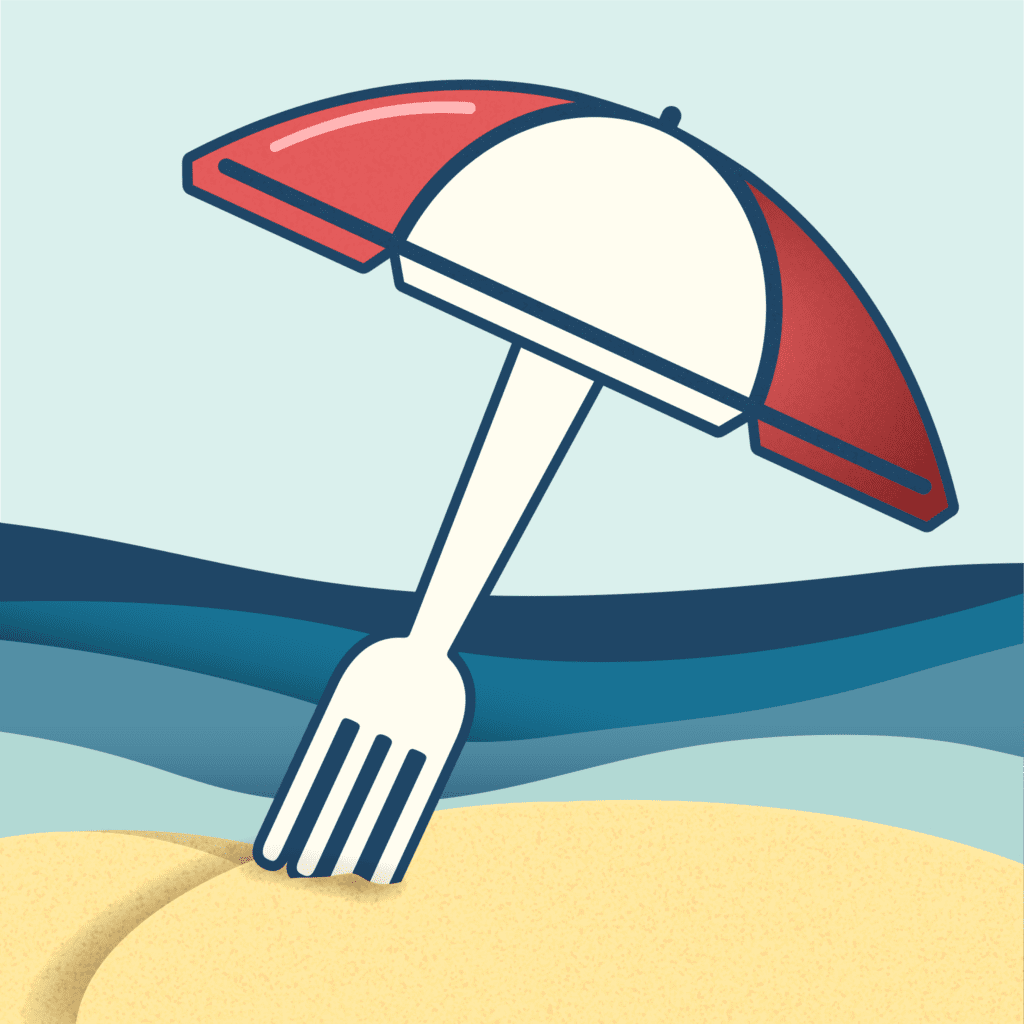Agosto. Talino Calarga (e vi assicuro che il nome è vero), venticinquenne artista di strada perso in un mondo irreale, balla senza sosta la sua musica techno a pochi passi dalla fontana dell’isola Memmia in Prato della Valle a Padova, incurante del solleone e del caldo. Mentre, divertito, lo osservo, assaporo per la prima volta una fetta di cocomero giallo. Una nuova varietà conosciuta anche come cocomero giapponese o coco-ananas ottenuto dagli agricoltori nipponici in modo naturale tramite innesto botanico.
Il cocomero giallo in Italia
Il cocomero giallo in Italia si coltiva principalmente in Sicilia, Basilicata e nell’Agro Pontino laziale. Il suo giallo vivo colpisce, ma i semi neri all’interno non mentono: è proprio un’anguria! Succosa, più piccola (pesa al massimo 6 kg), forse meno dolce ma più dissetante di quella rossa, è composta da oltre il 95% di acqua. La sua polpa croccante ha un sapore delicato che ricorda la dolcezza del mango con un retrogusto di ananas e fico d’India rendendola ancora più particolare.
Chi sarà stato lo “spiccatore” del cocomero (così è chiamato il Citrullus latanus in Centro e Sud Italia, qui al Nord, invece, lo chiamiamo anguria) dal quale è stata ricavata la mia fetta? Già, perché nelle campagne una volta era lo stacchino nell’Agro Pontino o lo spicador nella zona di Reggio Emilia colui che per professione, a prima vista e con brevi tocchi a mano aperta, riconosceva il frutto maturo pronto per la raccolta. L’esperto spiccatore controllava lo stato vegetativo della pianta, il cambiamento di colore della buccia, l’appassimento dello stelo (l’anguria con lo stelo riccio è più dolce di quella con lo stelo dritto) e il suono sordo del frutto picchiettato.
Analizzati questi segnali per la raccolta, procedeva legando la roncola a un bastoncino recidendo il peduncolo in un rito arcaico. Mestieri di una volta, testimoni di un mondo contadino che non c’è più. Un mondo dove il cocomero, passato dai fasti dei banchetti rinascimentali ai quali prestava forma e colore per sperimentazioni scenografiche o gastronomiche, era diventato un alimento che leniva la fame e apportava refrigerio. Costava poco produrlo e altrettanto poco era il suo valore di vendita.
L’Italia contadina del ‘900 si regalava qualche momento di riposo nei capanni costruiti con legno e frasche per la vendita dei cocomeri (dalle mie parti – in Veneto – venivano chiamate anguriare) e il gestore teneva i frutti in una grande tinozza di acqua e ghiaccio o sotto lo zampillo di una fontanella. Con il trascorrere degli anni i capanni sono diventati chioschi e sono arrivati anche in città regalandoci l’idea di estate. Ancora oggi per me il cocomero è quello che acquisto dai cocomerai (o anguriari in dialetto veneto): mi infonde aria di vacanza, mi evoca tavolate sotto freschi pergolati, ma anche mare e campeggi nelle pinete. Mi dimentico che sono a Padova, che sto guardando Talino e pensando che per lui sarebbe stata più consona una milonga. E che la mia fetta di anguria è davvero buona.